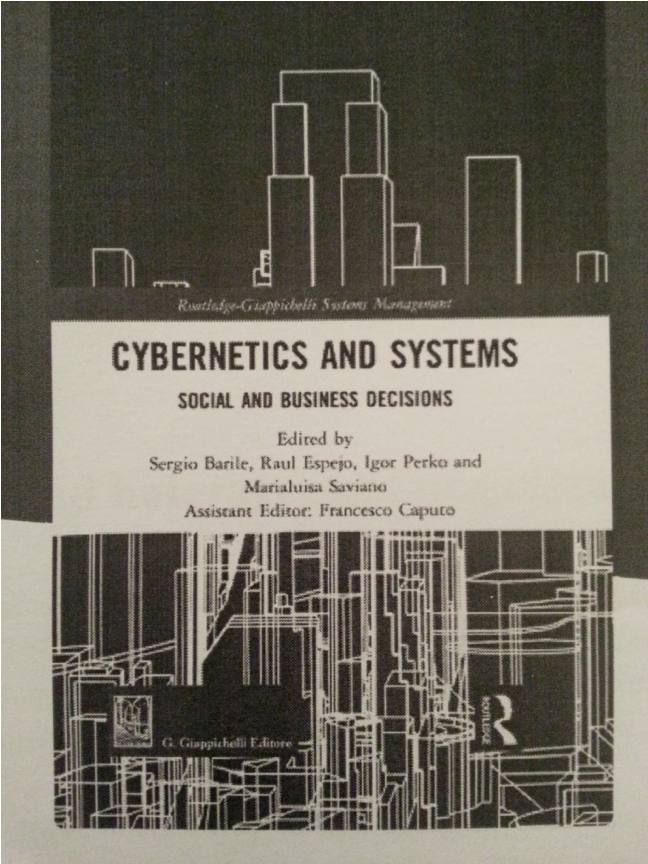Science never proves anything Gregory Bateson
Al suo posto e nel suo contesto ogni cosa è ragionevole e appropriata Sandor Marai
We live and breathe in dialogue and language Francisco Varela
1. Presupposti teorici: l’epistemologia cibernetica, una rivoluzione
Il modello sistemico relazionale, nato e sviluppatosi nel dopoguerra, si fonda sulla rivoluzione logica ed epistemologica proposta dalla neonata scienza cibernetica, la quale abbandona la logica classica fondata sulla causalità lineare in favore di una comprensione dei fenomeni complessi (ed in specifico dei fenomeni del vivente) in termini di circolarità, informazione, feedback e processualità.
Questo modello ha proposto una vera rivoluzione copernicana: suo fondamento teorico è il prestare attenzione alle relazioni piuttosto che agli elementi tra loro in relazione (l’ontologica relazionalità del vivente), centrando il focus sul “pattern che connette” gli oggetti e gli eventi tra loro, accogliendo la complessità, co-costruendola e gestendola, nello sforzo costante di evitare il riduttivismo e la semplificazione. Nell’ottica sistemica è il più complesso che spiega il più semplice: questo principio informa sia le ipotesi di comprensione dei problemi che le strategie di intervento. La complessità contestuale, lungi dal poter essere messa tra parentesi, come è sempre avvenuto nelle scienze classiche, viene considerata fonte primaria di comprensione e lettura oltre che risorsa principe nei processi di evoluzione dei sistemi. I sistemici prendono in considerazione la complessità, e cercano di mantenerla ad un buon livello di comprensione e gestione.
A partire da questi presupposti epistemologici l’approccio sistemico ha inizialmente rifiutato in modo netto il modello medico nella comprensione dei problemi dei singoli individui, per prestare attenzione all’individuo nel contesto: ciò che tradizionalmente è considerato ‘sintomo’ viene inteso come un comportamento comunicativo tra altri, ed ha un senso ed un significato coerenti al contesto di relazione entro cui si dà, partecipando al definirsi e al mantenersi delle ‘regole’ implicite del sistema, della sua organizzazione interna. Conseguentemente, l’obiettivo è la costruzione di possibili circoli virtuosi, l’accedere alle risorse – inderogabilmente presenti – spezzando i circoli viziosi che tanto facilmente si incistano e tendono a ripetersi sempre uguali. I sistemici hanno cercato di operare al di fuori di etichette a priori, di uscire dai percorsi usuali, di non perseguire le soluzioni tradizionali basate su concetti di ‘salute’ definiti a priori. Per un sistemico comprendere un problema non significa formulare una diagnosi individuale, bensì costruire un’ipotesi sul modo in cui elementi di natura psicologica e sociale diversi interagiscono tra loro: stili di interazione, significati, emozioni, modalità di regolazione delle stesse, alleanze, rapporti… per connettere tutto ciò ad un contesto più ampio.
È necessario aggiungere che il paradigma sistemico si è modificato profondamente negli anni ‘80, con il passaggio dal considerare i sistemi come osservabili dall’esterno (noi gli esperti, loro i pazienti) all’includere l’osservatore nel sistema osservato: in ogni momento l’osservatore si relaziona al sistema attraverso la propria comprensione del sistema, la quale modifica il rapporto con esso (Fruggeri 1992). L’osservatore non può più considerarsi esterno al sistema osservato, in grado di osservarne le caratteristiche senza influenzarle, capace di indurne il cambiamento in modo ‘istruttivo’ e prevedibile. L’oggettività viene posta tra parentesi (Maturana e Varela 1980) e si passa dall’osservazione dei sistemi ai sistemi osservanti, di cui anche l’osservatore fa parte (von Foerster 1982). Ne segue una concezione di tipo costruttivista secondo cui nessuna ‘costruzione’ o ri-narrazione del problema è utile di per sé, o a priori: solo l’evoluzione del sistema terapeutico dirà quale risulta utile in quella situazione specifica. Per questo, da una parte il conoscere ed utilizzare differenti teorie rappresenta una ricchezza ed un ampliamento delle potenzialità, ma, d’altra parte, credere in modo ‘forte’ ad una qualsiasi teoria, ed assumerla come unico parametro di riferimento e di narrazione, comporta il rischio di interferire con le potenzialità evolutive del sistema. Il ‘sintomo’ è ciò che viene consensualmente narrato e descritto come problema; esso perde quindi ogni carattere di oggettività: questo non deve essere inteso come un negare o misconoscere la sofferenza soggettiva, bensì come la possibilità sempre presente di costruire insieme un’altra narrazione che comporti un superamento della sofferenza medesima.
2. Approfondimento di alcune ipotesi patogenetiche
Come è possibile comprendere da quanto brevemente esposto, non è affatto semplice e non appare nemmeno coerente alla logica su cui il modello si fonda, parlare di eziopatologia all’interno del modello sistemico (il termine stesso ‘eziopatologia’ rimanda, in definitiva, ad una logica lineare causale). Ciononostante le differenti scuole di terapia familiare hanno proposto nel tempo differenti ipotesi eziopatogenetiche, pur nello sforzo costante di mantenersi coerenti ad una visione contestuale, relazionale, processuale.
Un primo gruppo di ipotesi sull’eziopatologia è da considerarsi interno alla teoria della comunicazione, nata in California, a Palo Alto, e conosciuta grazie alle pubblicazioni di P. Watzlawick. Secondo la teoria tutto è comunicazione e la comunicazione si organizza nel tempo secondo modalità circolari e retroattive: si organizza cioè in sistemi di comunicazione. Il sintomo è considerato come una risposta coerente ad un contesto di comunicazioni che presenta precise caratteristiche. Queste ultime rimandano sia ai differenti livelli di comunicazione che sono compresenti e tra loro embricati all’interno dei messaggi comunicativi, sia alla reciprocità del definirsi della relazione in corso. Vengono quindi proposti come possibili contesti comunicazionali all’emergere di un sintomo: 1) una incongruenza tra livelli di messaggio (ad esempio tra ‘contenuto’ del messaggio e tono con cui viene comunicato, ovvero il ‘commento’ che indica come intendere il messaggio stesso); 2) una escalation reciproca all’interno della relazione (l’escalation è un processo sempre più, che può essere di tipo ‘complementare’ – processo che esalta due comportamenti diversi e complementari: più l’uno è autoritario più l’altro è sottomesso – o di tipo ‘simmetrico’ – processo che esalta il medesimo comportamento nei due interlocutori: più l’uno alza la voce, più l’altro la alza a sua volta); 3) una difficoltà a livello di meta-comunicazione esplicita: la difficoltà a commentare verbalmente le caratteristiche della propria reciproca comunicazione e quindi la difficoltà di chiarire eventuali incomprensioni.
La prima di queste ipotesi è l’ipotesi che sta alla base del concetto di ‘doppio legame’, il modello forse più raffinato e sicuramente di maggior fortuna che l’approccio sistemico relazionale abbia inizialmente formulato. Questa ipotesi descrive un contesto di relazione (continuativo e caratterizzato dall’impossibilità di uscirne o di commentarlo) ove l’incongruenza comunicativa diviene per così dire la regola della relazione: chi vi si trova coinvolto viene posto in una situazione di profondo dilemma, e nella impossibilità di rispondere in modo appropriato ad una ingiunzione contraddittoria, la quale viene misconosciuta dall’emittente e non può essere riconosciuta dal ricevente (Bateson 1972, Sluzky e Ramson 1976). Si ipotizza che chi si trova intrappolato da una relazione che abbia queste caratteristiche formali avverta di ‘sbagliare’ sia che risponda in un modo sia che risponda in modo opposto: è in questo senso che si trova preso in un ‘paradosso’ ove l’unica risposta appropriata pare essere il sintomo, inteso come comportamento-comunicazione che a sua volta presenta caratteristiche paradossali (il sintomo, ad esempio, comunica: ‘mi comporto così, ma non dipende da me, bensì da una forza più grande di me’; oppure: ‘ciò che dico non lo dico io, ma le voci che parlano in me’). Come è noto la scuola di Milano ha inizialmente proposto in terapia un approccio controparadossale finalizzato a “sciogliere” i paradossi in cui le persone e il sistema in toto si trovavano, controparadossi che i terapeuti prescrivevano esplicitamente ai membri della famiglia in un contesto rituale spesso molto emotivo (Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata 1975).
Un secondo gruppo di ipotesi eziopatologiche si fonda sull’idea della famiglia in termini di sistema sociale in evoluzione, caratterizzato da proprie regole e da fasi di sviluppo idiosincratiche che se non rispettate portano alla patologia. Questi modelli pongono l’accento sia sugli aspetti strutturali della famiglia (dimensione sincronica), sia sugli aspetti evolutivi (dimensione diacronica): sia gli uni che gli altri aspetti implicano ruoli e regole diverse rispetto alla fase del ciclo di vita e alla collocazione sociale, e vengono presi in considerazione e confrontati rifacendosi ad una configurazione ottimale. Il modello strategico di Jay Haley e Cloe Madanes (Haley 1963, 1976, Madanes 1981) si fonda sul concetto di ‘potere’ nella relazione (Haley giunge ad affermare che “l’informazione è potere”), e quindi sulle coalizioni all’interno del sistema familiare, ipotizzando in specifico che la patologia emerga come risposta a coalizioni tra membri del nucleo familiare appartenenti a differenti generazioni (ad esempio tra un genitore e il figlio contro l’altro genitore) ove esse siano negate e misconosciute (concetto di ‘triangolo perverso’). Salvador Minuchin (1974, 1978), a partire dall’osservazione di configurazioni familiari tipiche rispetto a specifiche patologie (famiglie psicosomatiche, famiglie tossicodipendenti), descrive il sistema familiare in termini di ‘confini generazionali’, ipotizzando che la patologia emerga nel contesto di strutture familiari ove i confini tra generazioni non sono sufficientemente chiari (famiglie invischiate) o, al contrario, siano troppo rigidi e distanti (famiglie disimpegnate). È importante sottolineare che queste modellizzazioni sottendono l’idea di una comunicazione ‘sana’ (non contradditoria, ad esempio), e/o di una struttura familiare ‘normale’ (che presenti, ad esempio, confini chiari e permeabili tra generazioni), e intendono quindi l’intervento del terapeuta come sostanzialmente ‘normativo’.
Entrambi questi modelli pongono l’accento sull’ipotesi che l’insorgenza del sintomo si dia nel momento in cui il passaggio ad una differente fase dello sviluppo della famiglia richieda una modifica ed una ricalibrazione dei precedenti equilibri; viene quindi introdotto il concetto di ‘ciclo vitale della famiglia’, secondo cui alcune sintomatologie compaiono tipicamente nelle fasi di passaggio da un compito relazionale/sociale ad un altro: il passaggio dall’essere una coppia alla nascita dei figli, il passaggio dalla prima infanzia all’età scolare, l’adolescenza, il momento di definitivo distacco dalla famiglia del figlio con l’entrata nell’età adulta, la costruzione di una famiglia propria, il momento in cui la coppia nucleare si ritrova nuovamente sola. Si presta attenzione ai processi di individuazione dei membri (Bowen 1978) e di differenziazione tra le generazioni (Whitaker, 1984), processi che se non avvengono per tempo o compiutamente possono dare adito alla psicopatologia.
Terzo costrutto eziopatologico importante, e in parte derivante dai precedenti, è quello di ‘gioco familiare’. Il gruppo di Milano, formatosi intorno alla figura carismatica di Mara Selvini Palazzoli, pone maggiormente l’accento sulle caratteristiche sistemiche, cioè di connessione tra elementi della famiglia, intesa come ‘gruppo con storia’. A partire dalla osservazione di ‘ridondanze comunicative’ (sequenze relazionali che si ripetono indipendentemente dai contenuti o dagli argomenti discussi) l’équipe cerca di pervenire ad una ipotesi sulle regole implicite del ‘gioco sistemico’, ipotesi che sia il più possibile complessa e circolare, ovvero includa in modo significativo tutti i membri della famiglia ed eventuali persone esterne significative, ivi compresi gli invianti (Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata 1975). Inizialmente il concetto di ‘gioco’ viene applicato esclusivamente ai comportamenti osservabili, ma quando la teoria della comunicazione si emancipa da una concezione rigida e ‘letterale’ della metafora della ‘scatola nera’ è possibile interessarsi anche alle emozioni individuali e ai significati soggettivi. Il ‘gioco familiare’ diventa meno legato al qui-ed-ora, e diventa quindi storico ed evolutivo, e, soprattutto, viene identificato come epifenomeno che deriva dalle diverse interazioni emotive, cognitive e valoriali di tutti i membri di un sistema. Nasce un nuovo interesse al gioco inconsapevole che tutti insieme praticano e alla coerenza che ne deriva; per farlo emergere diventa fondamentale focalizzarsi sul punto di vista soggettivo, sulle emozioni, sulle premesse logico-emotive dei singoli membri della famiglia. Il piano strategico e tattico si affianca ad un livello semantico più ricco in cui si connettono tra loro le idee dei singoli partecipanti al gruppo. Si teorizza che il paziente tenda a portare in terapia un proprio sistema di coerenze, fatto di elementi tra loro connessi attraverso legami rodati: tale narrazione si presenta come un involucro traslucido ed inattaccabile (o comunque non facilmente attaccabile) di percorsi mentali interni, già esplorati e ripetitivi, di storie, relazioni, convinzioni e sintomi.
La successiva differenziazione tra l’équipe di ricerca diretta da Mara Selvini Palazzoli e il centro fondato da Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin porterà a sviluppi assai differenti: mentre il gruppo Selvini manterrà come centrale il concetto di ‘gioco familiare’, e cercherà di descrivere le caratteristiche specifiche dei giochi che fanno da contesto a sindromi specifiche, classificando così le famiglie secondo modalità che recuperano la logica normalità/patologia (famiglie a transazione schizofrenica, famiglie a transazione anoressica, ecc., Selvini Palazzoli e al., 1988, 1998), Boscolo e Cecchin si lasceranno profondamente influenzare dagli sviluppi teorici ed epistemologici della cibernetica, e diverranno tra gli esponenti più conosciuti a livello internazionale di un modello di terapia ‘costruttivista’, ‘narrativa’, ‘post-moderna’. Tale modello riconosce l’importanza cruciale dell’osservatore e delle sue premesse cognitive nel definire e mantenere il sintomo. Boscolo giunge ad affermare che ‘per fare uno schizofrenico sono necessarie tre generazioni più uno psichiatra’, e ritiene che il mantenersi entro una logica di sanità/patologia comporti il rischio di confermare implicitamente il problema e favorirne la cronicizzazione; inoltre egli scrive, con Bertrando, un libro sul tempo in terapia, sottolineando l’utilità clinica di parlare di futuro per co-creare con la famiglia percorsi possibili ancora non vissuti (Boscolo e Bertrando 1993). Cecchin scrive due importanti contributi (1993, 1997) sui pregiudizi del terapeuta, e sull’importanza che egli sappia essere ‘irriverente’ innanzitutto verso le proprie premesse implicite e le proprie teorie. Entrambi insistono sulla necessità di cercare le risorse e le potenzialità della famiglia e del sistema terapeutico più che osservare le difficoltà e gli aspetti patologici.
3. Segni e sintomi, la prassi sistemica contemporanea
Vorremmo ancora riflettere sugli aspetti di complessità e di problematicità che caratterizzano il modo in cui la terapia sistemica discute oggi di ipotesi eziopatologiche e, più ingenerale, del processo terapeutico.
Come abbiamo visto, la famiglia non viene più considerata un sistema con caratteristiche sue proprie, indipendenti dall’incontro con il terapeuta e con le sue premesse logiche e teoriche. Sarà l’incontro tra le teorie del terapeuta e le premesse della famiglia che definirà le caratteristiche del problema; tale incontro non sfugge al rischio di rivelarsi non evolutivo o, anche, involutivo – ove confermi di fatto la cronicità. Viene così messo l’accento sull’importanza dei pregiudizi del terapeuta (Cecchin 1987, 1997), sul rischio che l’adesione implicita ad una logica di sanità-malattia risulti iatrogena (Boscolo e al. 1987, Bianciardi e Telfener 1995), sul fatto che il terapeuta debba cambiare se stesso e il suo modo di vedere il problema piuttosto che cambiare l’altro.
Per quanto concerne il concetto di ‘diagnosi’, tutto ciò comporta che i livelli di diagnosi diventino multipli, che l’inestricabile strutturazione bio-psico-sociale dell’individuo e delle situazioni problematiche (e non) vengano sempre più comprese e approfondite. La complessità diventa un prerequisito indispensabile, fondato su un inevitabile dialogo interdisciplinare (psicologia, sociologia, antropologia, psichiatria, biologia,…), e su un collegamento sempre più proficuo tra modelli clinici (sistemico, psicoanalitico, cognitivista, esperienziale, gestaltico…) che aumenta i gradienti di libertà. Il disturbo mentale diventa epifenomeno di una costellazione di fattori di rischio di varia natura e a differenti livelli, e si considera che ogni singolo caso sia organizzato da pattern connessi in maniera differente. I livelli e i contesti di complessità relazionale diventano multipli e vanno presi in considerazione in momenti diversi del processo clinico: diversi livelli strutturali e narrativi che evincono come una medesima patologia può derivare da diversi percorsi e diverse costellazioni causali così come una stessa causa può condurre a diversi sintomi.
Le diagnosi diventano quindi il frutto delle scelte effettuate, delle vie percorse, consapevoli del fatto che ogni ipotesi diagnostica è un sapere specifico emergente da uno dei possibili livelli di complessità della relazione tra sistema osservato e clinico. E’ importante capire come e su cosa costruiamo le nostre ipotesi, non perché siano giuste o sbagliate ma perché possono risultare più o meno evolutive oppure omeostatiche, coerenti col sistema oppure troppo dissonanti, significative oppure incomprensibili per il nostro interlocutore, commensurabili con la prassi corrente oppure autarchiche. I ‘segni’ a partire dai quali faremo la nostra ipotesi diagnostica non sono inscritti nella situazione, sono post-scritti, perché la persona arriva con una miriade di elementi ed è il processo in atto che definisce quali verranno scelti e il percorso che si costruirà (Boscolo e Cecchin 1988, Bianciardi 1999, Peruzzi 1999, Mosconi et al. 1999).
Tornando quindi alle ipotesi eziopatogenetiche, è importante che il clinico non ‘sposi’ le proprie ipotesi, le consideri parziali e limitate, temporalmente valide solo se coerenti con la conversazione in atto. Solo se il clinico è in grado di riflettere sulla propria modalità generale di diagnosticare e, nello specifico, di ‘diagnosticare la diagnosi’ effettuata, si può parlare a nostro giudizio di una piena responsabilità terapeutica, intesa come la capacità di rispondere con coscienza del proprio operato emergente dalla relazione embricata tra conoscere e agire. La riflessività e la capacità di entrare in relazione diventano le operazioni cardine del processo. Non vi è ‘causa’ che si possa scoprire, non c’è una teoria eziopatogenetica che spicchi come teoria forte, l’attenzione deve tornare sempre al processo clinico.
In un’ottica costruzionista non si ricercano dati “veri”, si fa bensì emergere ciò che è coerente (ma contemporaneamente innovativo) con la situazione al fine di creare una “workable reality”, una realtà terapeutica efficace e percorribile che favorisca l’evoluzione anziché andare ad incistare i costrutti e i problemi stessi. Una costruzione diagnostica diviene così la capacità (l’arte?) di scegliere alcuni tra gli innumerevoli elementi che il paziente porta iscritti nella propria realtà e di riconnetterli in visioni pregnanti e significative per l’individuo, differenti da quelle proposte in primis. Sono queste “costruzioni” che rendono conto del fatto che, tra cento eventuali terapeuti, si instaurano infinite diverse possibilità di percorsi terapeutici, partendo da una stessa sintomatologia. La costruzione di più ipotesi contemporanee costituisce un rituale di modificazione delle mappe cognitive, emotive, relazionali del paziente, del suo sistema di appartenenza e conseguentemente del nostro rapporto con lui/lei. In questa prospettiva il clinico diviene chi, cogliendo alcuni segni possibili tra milioni di segni presenti – elementi scissi, frantumati, secondari, contraddittori per la persona che li emette – li ricollega a una organizzazione coerente e, attraverso la sua persona, costruisce una storia/narrazione plausibile e significativa comune agli interlocutori.
Come Keeney sottolinea (1983), il clinico partecipa ad una ecologia di idee cui non può non prendere parte, in quanto le sue unità di osservazione non sono gli individui ma piuttosto i processi mentali, che sono trasversali agli individui e anche ai singoli sistemi. Ciò che si conosce del paziente è ciò che è dato all’interno di quella specifica relazione costruita insieme, e nulla è conoscibile della sua “realtà” al di fuori di quel contesto. Il risultato è che il processo clinico viene caratterizzato, lo abbiamo già detto, solamente da processi di second’ordine. Cingolani scrive (1991): “Diventa importante riflettere sulle categorie impiegate e mettere in atto un processo di secondo ordine: una riflessione sulle categorie che hanno dato origine alle categorie emerse. Probabilmente l’idea di una diagnosi che si esaurisce in se stessa attraverso la ricerca e la categorizzazione degli elementi, porta a costruire un sistema, un insieme chiuso in cui, ogni volta che si ritrovano alcuni elementi “forti”, sembra di arrivare ad una diagnosi definitiva. Immagino invece che quegli elementi, quei segni, possano essere letti come un epifenomeno, un apparire rispetto ad una realtà che emerge dalle nostre costruzioni di questi segni. Il sintomo può essere anche un falso, oppure uno punto di partenza. Comunque si rintracciano e si disegnano delle piste tra gli elementi che si evidenziano… sempre e comunque piste che potremmo definire ‘diagnosi’ ”.
Stiamo parlando di una diagnosi della diagnosi, della riflessione sulle categorie che si sono utilizzate per fare diagnosi. È impossibile che il clinico non conosca anche le categorie nosografiche della psichiatria tradizionale. Ma ciò che conta è che la lettura nosografica non sia l’unica con la quale si approccia una situazione clinica.
4. Conclusioni
Tutto ciò che abbiamo detto fin ora comporta almeno una conseguenza molto importante: assumono grande rilevanza le tematiche relative alla responsabilità etica dello psicoterapeuta (von Foerster 1982, Bianciardi e Telfener 1995, Bianciardi e Bertrando 2002). Abbandonata ogni illusione di poter conoscere l’altro in modo ‘oggettivo’ e di poterlo influenzare secondo modalità prevedibili e protocolli di intervento predefiniti, e accettato il fatto che l’intervento dello psicoterapeuta non può essere considerato istruttivo bensì partecipa ad una comune costruzione di senso, vi è infatti il rischio che lo psicoterapeuta non si consideri responsabile di come il processo terapeutico evolve e si conclude. In realtà, al contrario, lo psicoterapeuta deve oggi riconoscere che la propria responsabilità, lungi dal poter essere elusa, diviene più piena, articolata e complessa: essa non si limita alla responsabilità professionale in sé, ma si rivela essere una responsabilità di second’ordine. Si tratta infatti di una responsabilità non solo relativa alla corretta applicazione delle metodologie e tecniche che il proprio modello prevede, ma relativa anche (e ad un altro livello) alle modalità stesse secondo cui si scelgono e selezionano le informazioni, le si connettono, vi si attribuisce significato: come il clinico interverrà nella conversazione terapeutica, infatti, non può prescindere dalle modalità costruttive adottate anche implicitamente – e anche a tale livello, quindi, lo psicoterapeuta deve sapersi pienamente responsabile e responsabile in prima persona.