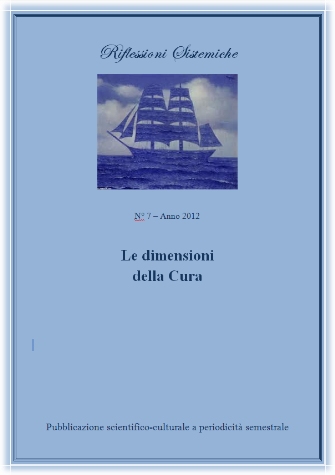THE CONCEPT OF CURE AND WHAT
WE THINK WE DO IN PSYCHOTHERAPY
Umberta Telfener, insegna alla Scuola di specializzazione in psicologia della salute dell’Università La Sapienza di Roma, è didatta del Centro milanese di terapia della famiglia.
Sommario: medicina e ambito “psi” propongono epistemologie, atteggiamenti e prassi diverse. Rifacendosi a von Foerster, queste differenze vengono evidenziate nell’articolo. Dal momento che il concetto di cura è identificato con l’ambito medico l’autrice suggerisce di non utilizzarlo nella psicoterapia. Non sceglie un altro termine ma evidenzia una prassi e ne parla estesamente. Summary: the medical and psychic domain are different. They assume dissimilar epistemologies, references, praxis and attitudes. These singularities are evidenced in the writing, giving words to Heinz von Foerster’ epistemology. Since the term “cure” is identified with the medical practice, the author suggests not to utilize it in psychotherapy. She doesn’t choose another term, she evidences a practice and talks about it extensively.
Riflessioni epistemologiche
Il mondo medico e il mondo della psiche (che coinvolge psichiatri, psicologi, e tutti gli operatori della salute) sono differenti e implicano operazioni e atteggiamenti diversi. Intendo nelle prossime pagine evidenziare queste differenze, ragionando sui due domini come ambedue indispensabili ed autorevoli, disuguali anche se non incommensurabili, per poi ragionare sul concetto di cura. Rispetto ai due mondi intendo riferirmi agli insegnamenti epistemologici di Heinz von Foerster (1987), mio mentore. Ciascun paragrafo, nel prendere in considerazione i due ambiti – quello medico e quello della psicoterapia – si rifarà ad uno degli insegnamenti del mio maestro. Rispetto alla psicoterapia mi riferisco al modello sistemico anche se credo che ormai i modelli, pur predicando teorie diverse, mettono in atto prassi simili tra loro, al punto che si può parlare di buone prassi e di quelle ridondanti e referenziali. Sosterrò che esistono due modi diversi di rapportarsi al mondo, uno lineare che privilegia l’ordine, la conoscenza come accumulo e scoperta, che considera il mondo un a priori cui ci dobbiamo adattare e un’altra che sostiene che la conoscenza deriva dalla partecipazione, che il mondo emerge dalle nostre azioni, che l’osservatore è implicato nel processo di conoscenza attraverso operazioni sulle operazioni e che l’autoreferenzialità ne è la conseguenza. Due modalità di procedere, di leggere gli accadimenti e di operare diversi ma non incommensurabili.
- L’esigenza di assumere una posizione epistemologica: i sintomi medici e quelli psicologici:
Chi abita il dominio medico si confronta con eventi che sono inevitabili nel corso della vita e che riguardano tutti. Ciascuno di noi ha diritto alla malattia, alle cure e ha un medico di riferimento che affronta sintomi oggettivi e standardizzati. La nostra salute è un evento naturale, un diritto a non venir discriminati e contemporaneamente un dovere sociale. L’aggravamento fa parte del processo. La medicina è dipendente dalla tecnologia e quasi sempre a-contestuale. Il medico osserva dall’esterno un sistema, considera le interazioni coll’altro istruttive, le soluzioni strumentali basate su predizione e controllo.
Il mondo psichico riguarda tutti ma i sintomi psichici riguardano solo alcune persone. I sintomi che si manifestano sono impalpabili e spesso vissuti come fossero da nascondere oltre che invasivi e difficili da decodificare. L’immateriale della mente rende i sintomi psicologici un evento straordinario, assolutamente soggettivo, collegato ad aspetti culturali e contestuali. Si tratta di eventi straordinari che vengono presi in carico in servizi dedicati e trattati in modi diversi, attraverso percorsi che molto dipendono dal curante, dal contesto e a volte anche dall’area geografica in cui si è. La cura necessita la motivazione alla cura stessa e ancora si rischia uno stigma sociale di “diversità” e follia. Benché in Occidente viviamo in un mondo che abusa di costrutti psicologici non abbiamo una alfabetizzazione al linguaggio della psiche per cui il suo manifestarsi come sintomo ci spaventa.
Raramente un utente chiede un colloquio clinico perché incuriosito dal significato della sua ansia, mai manifestatasi prima. Più spesso si presenta al colloquio spaventato e invaso da emozioni di annientamento, vivendo il sintomo come un intrusione che va al più presto silenziata. Di solito chiedo alle persone che mi incontrano di ringraziare i loro sintomi, di accoglierli come “doni” della psiche che finalmente si manifesta. Di considerarli un’occasione per alfabetizzarsi al proprio linguaggio interno, di aggiungere una dimensione alla propria vita che fin ora è stata appiattita agli aspetti comportamentali e razionali. Questa mia proposta di aprire alle emozioni anche negative, senza alcuna paura, viene inizialmente considerata “insolita”, permette poi a chi la accoglie di percorrere strade interessanti e non visitate prima. Così cerco la coerenza del sintomo nella storia dell’individuo e del suo sistema di riferimento e usualmente anche questo diventa bagaglio di nuova conoscenza e di perturbazione; quasi sempre di complessificazione di sé nel rapporto col mondo: un valore aggiunto. Il processo che in psicoterapia si propone è autoreferenziale, le soluzioni sono auto-generate dal processo messo in atto, il linguaggio diventa la danza sociale che fa emergere un mondo tra altri possibili.
- Le posizioni rispetto al sapere: elogio dell’ignoranza
Il mondo della medicina coinvolge professionisti che sono esperti nel loro campo, che debbono sapere e specializzarsi, essere in contatto con colleghi e proporre protocolli sempre più standardizzati. La medicina si basa sull’evidenza e privilegia il sapere scientifico e specialistico. L’inesperienza, così come la propria ignoranza si tendono a nascondere, considerandole pecche inaccettabili. I limiti vengono negati e si negano le carenze non solo personali ma generali della scienza e della disciplina specifica, come ha con forza sostenuto più volte Richard Smith, direttore del British Medical Journal (Cosmacini, Satolli 2003). Il mondo psichico obbliga a più posizioni contemporanee rispetto al sapere, posizioni che ci permettono di esplorare oltre il mondo specialistico specificamente connesso alla patologia, per spaziare in altri ambiti.
Ci spinge a sapere/conoscere la letteratura specialistica per pianificare i nostri interventi e non imboccare strade secondarie e per non ri-iniziare ogni volta da capo. Ci spinge a sapere molte cose per poter fare collegamenti, per attingere a spunti e fare nessi, ci obbliga a spaziare nel campo delle arti per conoscere cosa la mente umana ha prodotto e poterci avvantaggiare delle risorse presenti nella cultura e nell’animo umano. Il livello del sapere è infatti quello che rende possibile fare ipotesi su quanto sta accadendo.
Il sapere di sapere ci pone in una posizione di secondo ordine, la capacità di immetterci nel quadro e identificare come le nostre stesse idee e proposte abbiano effetto sulla danza relazionale che sta svolgendosi. Si tratta di un’operazione sulle operazioni fatte, una costante riflessione su cosa e perché. Un’analisi delle retroazioni conseguenti agli interventi proposti e una ridefinizione costante di sé e del progetto. Il processo dinamico non viene analizzato per essere fermato e reificato ma per riconoscerne la frequenza e per potersi sintonizzare su ciò che si è partecipato a far emergere. Il contatto e l’ascolto dell’utenza non è utile come raccolta di informazioni quanto piuttosto come strumento per far affiorare le risorse presenti e per riflettere insieme su come sostenerle/riattivarle. Qualunque definizione di un problema psichico non è legittima in senso oggettivo e una volta per tutte. La riflessività diventa lo strumento per agire/pensare/ operare in maniera etica. Implica anche la consapevolezza delle proprie conoscenze e della propria ineludibile ignoranza, la consapevolezza di sé oltre che dei processi che stanno accadendo.
Il non sapere è ineliminabile e non un minus rispetto alla nostra professionalità. Non possiamo sapere tutto, l’atteggiamento di non sapere permette una posizione di umiltà e l’occasione di dare potere all’altro e di considerarlo l’esperto della sua vita. Permette di dare credito agli altri e di considerare l’ascolto lo strumento privilegiato. L’ignoranza uno stato ineludibile: domandare per fare emergere ciò che è inascoltato, domandare al fine di ascoltare. Consente infine di riconoscere la nostra posizione come quella di coloro che hanno bisogno di imparare dall’altro. “Cosa devo sapere di voi in modo da potervi aiutare?” è una domanda che spesso consiglio di fare, soprattutto in contesti nuovi, ma non solo.
Il sapere di non sapere è ciò che alimenta la curiosità. Considerare la possibilità della propria ignoranza nel dominio clinico implica rinunciare al proprio expertise. Le situazioni vanno considerate imprevedibili perché sono sempre più complesse rispetto alla narrazione portata, le scelte a volte indecidibili; pensare e agire sapendo che siamo ignoranti fa sì che in seduta si facciano accadere alcuni eventi, si lavori sugli spigoli che emergono, sulla nostra partecipazione, senza pretendere di controllare e conoscere il mondo dell’altro.
Il sapere di non sapere permette di tollerare gli errori come inevitabili, purché ci si accorga del processo e si sia disponibili a rivederlo. Gli errori per i medici diventano un’onta, anche per il rischio vita che possono implicare. Il mito del medico che non sbaglia mai e che comprende al primo incontro ciò che sta accadendo è duro a morire. Silenzio e omertà rischiano di contraddistinguere ambedue le caste, sempre di più. Quando ho curato insieme a Marco Bianciardi un libro sul rischio del rischio iatrogeno, abbiamo chiesto un contributo a rappresentanti di diversi modelli di psicoterapia. Alcuni ci hanno risposto che “i panni sporchi si lavano in famiglia” quando la nostra posizione era che gli errori in ottica cibernetica non si potessero evitare e fossero utile fonte di apprendimento (Bianciardi, Telfener 1995).
Il non sapere di sapere ci permette di utilizzare l’intuito e l’improvvisazione. Si tratta della fiducia nella possibilità di non dover decidere ogni nostra mossa per fidarci invece della nostra pancia. La possibilità di dare credito alle proprie intuizioni cliniche si matura col tempo e costituisce un’utile strumento terapeutico, a volte la mossa decisiva per uscire da un empasse. La psicoterapia non è un’operazione unicamente razionale, è un incontro tra persone, che mette in comune emozioni, visioni del mondo, irrazionalità, inconsapevolezze. L’improvvisazione, come la capacità di mostrarsi irriverenti, è sicuramente uno strumento utile in quanto permette di cambiare il livello di attenzione, di slittare nel discorso, di uscire da una logica troppo stretta e satura.
Il non sapere di non sapere implica la consapevolezza della nostra cecità e ci confronta con la necessità di fare i conti con gli esiti indesiderati, con la collusione e la risonanza. Sapere che si è inevitabilmente ciechi implica ancora di più. Significa: 1.rinunciare al controllo del sistema di cui facciamo parte perché comunque questo controllo non è sotto la nostra consapevolezza; 2. immaginare la situazione terapeutica come oggetto frattale (una figura in cui un motivo sempre identico si ripete su scala più piccola o ampliata) al fine di lavorare sullo spigolo che emerge in rapporto a noi; 3. mettere in atto una “conversazione sul possibile (Mc Carthy 2010)” che renda accettabile di muoversi in maniera co-creativa, rinunciando a verità, rigidità, certezze; 4. accontentarsi di far accadere in seduta alcuni eventi e costruire una workable reality; 5. monitorare costantemente la possibilità di entrare in risonanza, di costruire interventi che siano ortopedici o collusivi; tenere a mente il rischio, sempre presente, di costruire interventi che, seppur ben confezionati, non producono quell’evoluzione per la quale siamo stati ingaggiati (Telfener 2011).
3. L’epistemologia incarnata: la cultura di riferimento come parametro imprescindibile
La medicina sta diventando sempre più specialistica. Il mito del medico a tutto campo che può rispondere ai bisogni di salute del paziente è tramontata, anche se ancora resiste l’ideale della medicina come scienza esatta, razionale. La potremmo definire una scienza verticale che tende a separare la soggettività e la realtà sociale della persona dalla biologia, che disgiunge gli ambiti e le discipline, per trattare ogni organo separato da ogni altro, rischiando di non considerare l’individuo nel suo insieme. Una pratica che sempre più si rifà a metodi oggettivi e linee guida e che utilizza privilegiatamente un paradigma positivista. La malattia ha una connotazione negativa, priva di un significato più generale. Raramente viene preso in considerazione il punto di vista darwiniano, storico-evolutivo, orizzontale, per cui i problemi e i sintomi sono considerati come compromessi rispetto al miglior modo possibile di funzionare. La medicina si rifà ad un sistema eteronomo e si riferisce a problemi spesso avulsi dal contesto e privi di una dimensione ecologica. La metafora preferita è quella per cui le cose nascono a seguito di fenomeni interni : il DNA determina che quel seme diventi una quercia, per esempio, senza tener conto che lo diventerà anche in base al sole che lo scalda, all’acqua che lo bagna e al tipo di suolo in cui si è trovato; il DNA potrebbe annunciare una malattia genetica ma la sua insorgenza dipenderà anche da condizioni psicologiche, dagli eventi di vita, da ciò che accade al singolo individuo.In psicoterapia tentiamo di gestire la complessità e di connettere diversi parametri. L’individuo lo consideriamo nel suo contesto, collegato agli antenati oltre che dipendente dal campo. Cerchiamo piccoli ordini provvisori, narrativi, e ci definiamo costruttivisti. Operiamo nel regno delle connessioni, in quella che Hoffman (2001) definisce l’arte dell’essere testimoni creativi. Rinunciamo così alla separazione degli ambiti e delle discipline, alla posizione di esperti e favoriamo la posizione del sapere di non sapere e la consapevolezza dell’ineluttabilità di esiti indesiderati. Il processo diventa co-definito ed emerge dalla danza che insieme si fa.
4. L’impostazione dei problemi: gli umani come macchine non triviali
In medicina i pazienti arrivano con un problema oggettivo (un braccio rotto, un cuore che funziona in maniera irregolare, il sangue che non si coagula, la presenza di un corpo estraneo o di un virus). In medicina si è soliti occuparsi dell’organo bersaglio e del problema presentato. Diagnosi e terapia si fondono.
In ambito psi siamo confrontati con domande indecidibili e con sistemi indeterminati e dobbiamo fare i conti con la soggettività. Consideriamo gli umani macchine non triviali cioè imprevedibili e mossi da motivi sempre diversi e non definiti dall’esterno. Le soluzioni auto-generate emergono dal processo in quanto diventiamo catalizzatori e partecipanti attivi ad un sistema che si auto-organizza: gli interventi che facciamo non derivano da procedure oggettive ma emergono dalla danza che danziamo con gli altri. L’oggetto di osservazione consiste dell’atto stesso di osservare l’oggetto, come propongono la chiusura operazionale e la riflessività. La costruzione di più ipotesi contemporanee costituisce un rituale di modificazione delle mappe cognitive, emotive, relazionali del paziente, del suo sistema di appartenenze e inevitabilmente del nostro rapporto con lui/lei e di noi stessi. Il nostro cliente ci indica vie di fuga nella storia che ci porta e noi prestiamo attenzione alla forma del dialogo, alle aspettative, alle emergenze. Sono le cose insolite quelle che attirano la nostra attenzione e che andiamo ad amplificare al fine di allontanarci dal solito copione per co-costruire un nuovo percorso conoscitivo, uscendo da schemi soliti.
5. La conoscenza scaturisce dall’azione: la molteplicità dei livelli di intervento
I medici privilegiano un livello specialistico collegato con il problema presentato. L’anamnesi serve per comprendere meglio i sintomi e migliore è il medico che focalizza più chiaramente sul problema presentato, assumendo un atteggiamento centralista e lineare. Gli aspetti culturali offrono scarse (ma non nulle) informazioni. Sappiamo bene che ogni intervento ha implicazioni sociali oltre che personali e relazionali e include il livello delle azioni ma anche dei pensieri e delle emozioni. Non sempre i medici tengono conto di questi aspetti.
I nostri interventi psi obbligano ad un maggior numero di livelli di analisi e di intervento. Così come l’organismo umano è da noi meglio compreso se rappresentato come un sistema facente parte di sistemi più ampi – la famiglia di origine, la comunità di appartenenza, la professione, il contesto culturale, l’ambiente in cui vive – anche gli interventi implicano una molteplicità di posizioni. Ci posizioniamo su più modalità del conoscere, proponiamo più ipotesi interpretative, cerchiamo più posizioni nella relazione (collaborativa, strategica, apprezzativa, inquisitoria; contemporaneamente interna, esterna, ‘meta’), prendiamo in considerazione più aspetti … Direi che la molteplicità è una caratteristica predominante dell’atteggiamento epistemologico.
E’ necessario che facciamo per ogni problema un’analisi del contesto: chi è l’inviante, chi ci telefona, chi è rispetto al paziente designato, per chi è l’intervento richiesto, quale mandato abbiamo dall’istituzione in cui operiamo, chi sono i nostri interlocutori, chi decidiamo di convocare … Ma anche che significato ha il sintomo all’interno della cultura della persona e del luogo e del sistema che abita. Potremmo addirittura definire il professionista come un costruttore-gestore di contesti.
Il livello interpersonale implica attenzione alla domanda e alla sua ridefinizione, al fine di arrivare ad una definizione comune del problema sul quale lavorare. Quello che conta è il pattern di collegamento con gli altri che emerge dall’analisi della domanda: perché sono venuti ora, cosa ci chiedono, quali sono le aspettative, quali le risorse in campo. Cosa possiamo fare per loro, come possiamo “smontare” il problema presentato e accordarci per un “nuovo” obiettivo comune. Diventa poi fondamentale che teniamo conto anche delle idee, delle premesse, del modello di mondo e delle convinzioni dei nostri interlocutori in quanto la danza che si instaurerà verrà influenzata dallo scambio e da ciò che emerge dalla danza stessa. L’analisi delle dinamiche nella relazione con noi costituiscono aspetti interpersonali.
Laura Fruggeri (2008) propone che ogni clinico gestisca un livello relazionale e un livello tecnico/strategico. Il primo ha a che fare con una riflessione sulle proprie azioni e sulle proprie premesse al fine di monitorare come contribuiscono alla costruzione della relazione, anche con una riflessione sul significato che l’intervento assume rispetto al contesto del cliente. Il livello tecnico invece implica l’elaborazione del miglior intervento possibile, la strategizzazione rispetto a come intervenire. Ambedue questi livelli coinvolgono competenze diverse: a livello relazionale la capacità di costruire un contesto interattivo nel quale i clienti sviluppino le risposte ai loro bisogni, nel quale possano sviluppare le loro competenze. A livello tecnico la conoscenza delle strategie, delle metodologie e della coerenza tra epistemologia e interventi. Le nostre specifiche esperienze entrano in campo esattamente come in ambito medico. La trasparenza, intesa come l’occasione di condividere – ove lo riteniamo utile – aspetti personali, diventa un valore per noi e non lo è per i medici, i quali raramente si mettono in gioco a livello individuale.
6. Le scelte dell’osservatore: chi convocare?
In medicina si convoca chi porta il problema: il malato, il paziente. Gli altri sono visti nel migliore dei casi come risorse, altrimenti come personaggi cui prestare un minimo di attenzione. In ambito psi è necessario sempre decidere cosa far emergere, cosa mettere in luce rispetto ad uno sfondo. Una delle scelte terapeutiche iniziali è se vedere una persona da sola oppure con la sua famiglia o con il partner; se convocare la terza generazione, i nonni, oppure lasciarli a casa. Il costrutto di sistema determinato dal problema, concetto di Anderson e Goolishian (1988), è molto utile e interessante in quanto sostiene che non è un sistema a produrre patologia (visione lineare e semplicistica) ma i professionisti dovrebbero convocare le persone che condividono la definizione semantica del problema. In questo caso può diventare utile convocare un insegnante, un pediatra oppure il capufficio.
La salute è un valore positivo, un bene che si raggiunge attraverso informazione e consapevolezza, anche se malati. Non si tratta del completo benessere fisico, psichico e sociale quanto di una stato esistenziale cui si attribuisce un valore positivo. Ambedue gli ambiti, quello medico e quello psi, rischiano di basarsi sempre più sul bisogno dei pazienti/clienti e sulla necessità di far loro consumare sempre più prodotti, che siano pillole, interventi, sedute di psicoterapia, ricoveri, visite specialistiche. Per continuare a crescere, l’industria della salute in ambedue i domini sta rischiando di reificare la malattia sulla quale sostiene di intervenire. L’ipotesi dello psichiatra di base, dello psicologo di base, il ticket per le prestazioni psichiatriche e psicologiche, gli screening, i controlli mirati e specifici portano a cercare malattie già in atto anche se nascoste e rischiano di produrre un clima di patologia, attraverso un effetto sommatoria che guarda alla medicalizzazione e che riduce sempre più lo spazio della normalità, producendo circoli viziosi. Nell’industria della salute non solo le industrie farmaceutiche cercano nuovi farmaci per i disturbi esistenti ma cercano nuove malattie per i farmaci che devono vendere (disease mongering, mercato delle malattie).
7. L’interazione ineludibile: il significato dei sintomi
Non è ancora tramontato tra i medici l’abitudine a considerare il corpo umano come una macchina e la malattia come un guasto da riparare. Il vocabolario è spesso tecnico, il tempo raramente viene preso in considerazione. Se il sintomo è l’epifenomeno di una catena di causazioni che ha origini chissà dove e si compone di una sequenza di retroazioni, al medico raramente interessa. I disturbi vengono decontestualizzati per essere diagnosticati in base a segni e sintomi. La medicalizzazione tende a marchiare un sintomo come difetto, definirlo con una diagnosi razionale/specialistica privata di un significato relazionale e adattativo, a volte imposta alla persona anziché costruita insieme. Una diagnosi che ‘colpisce’ il singolo e rischia di isolarlo dalla condivisione con il proprio gruppo di riferimento. Curare implica essere immessi in un protocollo. Si tratta di una pratica clinica avulsa dalla soggettività, implica isolare ed espellere, a volte negare.
Noi psi prestiamo una particolare attenzione alla storia personale dell’individuo e alla sua interazione con gli altri, di una determinata società e cultura, spostando l’attenzione dalla natura del singolo alle interazioni socioculturali nell’arco del tempo. Ci interessiamo dei meccanismi di vulnerabilità e resilienza. Il processo di guarigione è infatti facilitato da fattori di resilienza che riducono al minimo l’intensità dello stress acuto dell’individuo, permettendo una modulazione più rapida e funzionale delle reazioni (utile il riappropriarsi delle proprie reti sociali).
La diagnosi non può essere per noi una descrizione delle caratteristiche del sistema osservato. Possiamo/dobbiamo interrogarci sul ‘dia‘ che il termini dia-gnosi contiene, ovvero su ciò che attraversa (sulle teorie in campo, sulle premesse dei partecipanti, sui pregiudizi, sulle emozioni che stanno influenzando il processo, ecc.) e sulle scelte che compiamo. Una costruzione diagnostica diviene così la capacità e l’arte di scegliere alcuni tra gli innumerevoli elementi che il paziente porta iscritti nella propria realtà e di riconnetterli in visioni pregnanti e significative. Queste “costruzioni” instaurano infinite diverse possibilità di percorsi terapeutici partendo da una stesso problema. Mettiamo spesso in atto una diagnosi della diagnosi, una riflessione sulle categorie che si sono utilizzate per fare diagnosi. Ciò che il clinico cerca di conoscere, non esiste prima che incontri l’altro ma emerge nella danza: le caratteristiche dell’incontro infatti vedono la luce entro la storia comune e non sono prevedibili. Coinvolgono le esperienze, le idee e le emozioni di tutti i partecipanti. Ciò che emerge, emerge dalla collaborazione di più teste/cuori/persone che agiscono su materiale vivente in perenne riscrittura e trasformazione.
8. Interessarsi alle regole di composizione: l’esito degli interventi come risultato delle operazioni di secondo livello
I successi e i fallimenti in ambito psi non dipendono unilateralmente dal professionista o dalla gravità del problema. Sono invece generati all’interno della storia della relazione e del reciproco incontro. All’interno di un’epistemologia cibernetica niente è giusto o sbagliato in se stesso. Può invece venir definito in un modo o nell’altro all’interno di una cornice relazionale e di un contesto. Non abbiamo bisogno di acquisire nuove tecniche, di inventare teorie sempre più sofisticate per avere a che fare coi sistemi e i contesti. Abbiamo bisogno di riflettere sempre di più sulle operazioni che facciamo, in modo da permettere uno svolgimento evolutivo, responsabile e processuale. Che implichi processi riflessivi di secondo livello.
I successi e i fallimenti emergono dalla coordinazione della coordinazione di azioni e significati. Come scrive Bianciardi (1999): “Le parole e le azioni che facciamo e che non facciamo costruiscono la danza e possono portare o non portare agli effetti desiderati, proprio in virtù del fatto che, in un processo di co-costruzione, non è solo l’operatore a determinare gli effetti di ciò che mette in atto ma saranno anche e soprattutto tutti gli interlocutori (sempre plurali) ad attribuire un “senso” a ciò che viene espresso in parole e azioni, retroagendo sulla base di questo “senso” attribuito. Solo un’ipotesi e un intervento che emerga dall’embricazione di tutte le convinzioni in gioco può risultare evolutiva, altrimenti si instaurerà una lotta di potere (spesso tacita) che porterà il paziente designato a venir preso in mezzo e a poter rispondere soltanto con i sintomi (di più dello stesso). ”
Così la cronicità non dipende dalla gravità della psicopatologia o dei sintomi, neppure dalla gravità del disturbo di personalità ma emerge nella relazione tra il portatore di sintomo, il suo sistema di riferimento e il sistema curante. Anche il curante entrerà nel processo e potrà portare con i suoi interventi a soluzioni evolutive oppure alla cronicità.
9. Il sistema osservante e il problema dell’inclusione: l’uso di sé
I medici di medicina generale e specialistica usano naturalmente le proprie competenze ma solo da poco insegnano che parte della cura è se stessi. Il “vecchio” medico condotto era soprattutto una persona connessa con i suoi pazienti. C’è poi stato un periodo di totale tecnicismo e ancora nelle scuole mediche si insegna agli studenti di dimenticarsi gli aspetti umani del paziente, per concentrarsi sull’organo. Ancora si chiede loro di non coinvolgersi troppo personalmente, benché si riconosca che la relazione è il fulcro del rapporto di aiuto e consiste in una comunicazione tra due esseri umani, uno che fa domande e l’altro che fornisce risposte. La raccolta dell’anamnesi resta il momento “più intimo” di questa relazione e i dati vengono spesso raccolti in maniera cronologica e lineare, facendo poche connessioni. Interessante considerare che i malati usualmente chiedono ai medici competenza (sapere cosa sta accadendo) e disponibilità (generosità di tempo ed energie, partecipazione). Interessante perché sono quelli che riescono a gestire bene questi due ingredienti quelli che verranno più gettonati. La disponibilità a somministrare se stessi paga!
Per noi si tratta sempre della necessità/capacità di utilizzare noi stessi per riflettere sulla danza che si conduce con gli altri. La riflessività è considerata una modalità per riflettere sul processo in atto, in modo da rinviare alle azioni che si sono compiute e alle conseguenze che ne sono derivate. Si tratta della capacità di sintonizzarsi sui costrutti utilizzati e su come ciascuno ha reagito ad essi. Di ragionare su quanto è emerso dalla danza relazionale comune. L’atteggiamento di apprezzamento non è quello “tutto americano” per cui ridefiniamo qualsiasi comportamento come adattativo, non abbiamo paura di criticare quanto avviene. Ridefinire significa non aver paura dei sintomi e dei disturbi, non etichettarli come segnali di malattie ma come un possibile funzionamento dell’individuo/mente che ci sta segnalando qualcosa. Le persone sono in controllo della loro storia o possono diventarlo e il clinico deve decidere cosa fare e far fare, non in maniera direttiva, attraverso una strategizzazione puntuale anche se non unidirezionalmente definita. Non è il consenso ciò che ci guida ma le differenze che introducono differenze, che permettono una eterogenea lettura degli accadimenti e permettono di entrare in campi inesplorati.
10. a posizione etica ineludibile: livelli molteplici di responsabilità
La responsabilità dello psicoterapeuta non può essere quella di conoscere in modo prevedibile e comportarsi secondo protocolli di intervento predefiniti; sarà piuttosto l’assumersi la responsabilità delle modalità del proprio proporsi e delle sue scelte, all’interno della danza in costante divenire.
Oltre ad una responsabilità professionale e tecnica, alla necessità di essere capaci nel nostro ambito – responsabilità che condividiamo con i medici – credo che in ambito psi ci sia anche una responsabilità relazionale che implica la disponibilità a riflettere sul significato che i nostri interventi assumono per le persone che interagiscono. La necessità di prendere in considerazione se i nostri interventi sono processuali, se invece contribuiamo allo status quo. E’ per noi costantemente necessario considerare se stiamo colludendo con la situazione oppure introduciamo informazioni che creano una differenza. Abbiamo anche una responsabilità sociale quando siamo chiamati a decidere se una situazione è pericolosa per la crescita emotiva di una persona, per il suo benessere; quando dobbiamo decidere se allontanare un padre da un nucleo o rimuovere un minore da una famiglia. Dobbiamo quindi riflettere come le nostre azioni contribuiscono o meno a mantenere una struttura di potere. Abbiamo certamente una responsabilità personale nei nostri confronti in quanto facciamo un’attività ad alto rischio di burn out e in quanto interveniamo nella vita degli altri in maniera a volte significativa. Come i medici abbiamo la responsabilità di continuare a crescere professionalmente. In ambito psi abbiamo anche la responsabilità di crescere come persone, sia emotivamente che spiritualmente: il compito di costruire una visone interconnessa degli eventi e delle nostre conoscenze e di allargare le maglie con le quali osserviamo gli eventi (interessante come anche Paracelso pensava che il medico dovesse lavorare su di sé per poter poi prendersi cura degli altri: sosteneva che dovesse “bruciare” cioè temprarsi, mettere in atto un processo mentale per eliminare le scorie e le negatività). Fa parte della responsabilità personale di noi psi avere consapevolezza di sé e delle proprie strategie di relazione: conoscersi e accrescere il processo di consapevolezza in relazione agli altri. Chi sono io? Cosa penso? Che idea ho della situazione che mi è stata descritta? Ma anche, necessariamente, chi è l’altro? Cosa mi porta? Cosa stiamo costruendo insieme? E, ancora, quali categorie ho utilizzato per leggere la situazione? Ho aperto spazio a possibilità evolutive oppure le ho limitate? Quali azioni derivano da ciò che stiamo dicendo insieme?
C’è infine una responsabilità reciproca (mi fido che tu ti fidi di me? E tu ti fidi che io abbia fiducia in te?) ed una responsabilità della co-responsabilità, che si riferisce al dover rendere conto, per primi a se stessi, del processo di costruzione delle realtà sociali che emergono nell’interazione tra il problema presentato e il sistema di significati implicito (Bianciardi, Galvez 2012).
Il concetto di cura
Innanzitutto una storia, inusuale, che racconta Paolo Fabbri recuperandola dagli scritti di Heidegger e Goethe, definendola una testimonianza pre-ontologica (in Donghi, Preta 1995): la cura stava attraversando un fiume quando scorge del fango cretoso. Decide di dargli forma. La raggiunge Giove che infonde lo spirito a questa creazione inconsapevole. La cura vuole anche imporre un nome alla sua opera ma Giove non è d’accordo. Mentre i due litigano interviene la Terra che reclama il battesimo di ciò che è stato fatto col suo corpo. I litiganti eleggono Saturno, il Tempo, come giudice tra loro. La decisione di Saturno è ferma: Giove che ha dato lo spirito riceverà lo spirito indietro al momento della morte; la terra ha dato il corpo e riceverà indietro il corpo. Siccome è stata la cura a dare forma a quest’essere, finché vivrà lo possiederà la cura. Per tutta la vita l’essere umano è l’essere della cura e visto che proviene dalla Terra (humus) il suo nome sarà uomo.
Qual è lo scopo della medicina? Non solo l’integrità fisica e il buon funzionamento generale; anche il benessere soggettivo, la salvaguardia dell’autonomia e libertà dell’individuo. C’è poi una dimensione sociale della medicina che cambierà di momento storico in momento storico, di paese in paese. Cura, prevenzione, intervento sono le operazioni costituenti la medicina, sono le azioni che si mettono in moto. Il concetto di cura è dunque strettamente connesso alla medicina e spero, nelle pagine precedenti, di aver mostrato come medicina e psicoterapia siano pratiche epistemologicamente e operativamente diverse.
Se è pur plausibile che il significato originario di curare è ‘prendersi cura’ cioè esaminare, analizzare e amministrare una situazione patologica, la cura ha perso il connotato processuale di scambio e di dialogo, per riferirsi sempre più ad una prassi che implica un forte squilibrio tra gli attori del processo stesso e impone una forte attenzione ai risultati in termini di guarigione o fallimento. Si è persa l’immagine del medico come di colei/colui che come un buon timoniere è capace di non portare la sua nave a scogli (Donghi, Preta 1995). L’emergenza della medicina scientifica agli inizi dell’Ottocento ha separato il concetto di ‘cura’ e di ‘prendersi cura’ e sebbene in inglese esistano ancora oggi due termini diversi (‘cure’ e ‘care’) per indicare le due funzioni, da noi il termine “curare” sempre più si riferisce al trattamento ed è connesso alla guarigione da una malattia. Il medico non chiede più l’aiuto del malato, come avveniva nella medicina ippocratica, ma si rifà alla tecnica, ai laboratori, alla farmacologia e sempre più alla genetica.
Il concetto di ‘cura’ appare a mio parere fuorviante quando applicato alla psicoterapia, in quanto inscritto in una logica lineare e semplice e troppo medica. Implica ritenere possibile che il clinico sia separato dal sistema su cui interviene ed agisca su di esso in modo istruttivo, sapendo dove intervenire, quando, come e perché. I concetti di intervento e cura sono inscritti in una logica lineare, per cui “qualcuno” separato dal sistema agisce su di esso in modo istruttivo. Anche il concetto di prevenzione è obsoleto e noi psi preferiamo il termine “promozione della salute” come movimento attivo verso qualcosa di positivo (pro-muovo, vado verso il benessere) anziché come mossa di difesa da qualcosa che si considera inevitabile (pre-venio, vengo prima del dolore e della malattia).
Più interessante semmai introdurre il concetto di ‘intervento dell’intervento’, ‘cura della cura’, che permettono di prestare attenzione a come il processo che definiamo ‘cura’ evolve nel tempo e a come evolve dalle azioni comuni. Implica infatti riflettere sulle modalità secondo cui stiamo partecipando a intessere le trame di significato che emergono dall’incontro. Personalmente suggerisco di non usare il costrutto di cura neppure nella sua declinazione riflessiva.
Un’alternativa alla cura: creare uno spazio condiviso di riflessione
Non ho scelto un nome per definire la psicoterapia in modo alternativo a “processo di cura”. Alcuni la chiamano operare nel regno delle relazioni, pratica collaborativa, inchiesta riflessiva, narrazione, pratica dialogica. Nessuno di questi nomi mi piace in quanto mettono tutti troppa enfasi sul linguaggio. Il nostro lavoro è sia epistemologico che cognitivo/emotivo; si tratta di una prassi in cui facciamo (fare domande, dialogare, fare ipotesi, indagare attivamente …) e facciamo fare (azioni congiunte, compiti a casa e in seduta …) al fine di modificare le condizioni di possibilità. Si tratta di un processo in cui tutti gli aspetti cognitivi/emotivi/ comportamentali/linguistici sono messi in gioco contemporaneamente.
Preferisco chiamarla pratica sistemica. Come scrive von Foerster (in Telfener, Casadio 2003): “La mia proposta è quella di inventare un nuovo termine che è quello di sistemica, come sostantivo. In questo modo la sistemica diviene un modo di osservare, di porsi di fronte al mondo. … La prassi sistemica si fonda sul dialogo, su una modalità tipica di attenzione alle relazioni umane che restituisce la scienza al suo dominio originario, al dialogo umano. … La sistemica è interessata alle regole di composizione. Si occupa soprattutto dell’interazione tra le parti. Propongo di considerare la sistemica come una posizione, un modo per osservare, un atteggiamento conoscitivo. Operare una distinzione è scientifico, vedere la complementarità è sistemico. In quest’ottica i concetti si embricano attraverso la mutua definizione di sé e dell’altro. (pp.79)”
Come operatori della psiche non abbiamo il compito di identificare malattie. Siamo chiamati a ragionare sui processi che emergono dalla confluenza di problemi e risorse, all’interno di un contesto definito da noi e non dato a priori. La salute mentale ha a che fare con lo sviluppo e la realizzazione di sé.
Avere sintomi è parte del processo di salute, avere un pattern di personalità serve per crescere. Gli operatori sono presi tra più fuochi e devono imparare a rinunciare, come motivazione primaria del lavoro psicologico, a ogni fantasia di cura, guarigione, crescita, miglioramento del sé, consapevolezza; non devono cercare l’adattamento, non proporre l’integrazione, rinunciare alle interpretazioni, ad una salute mentale pensata come a priori (Telfener 2011, b). Non si tratta neppure di aumentare la consapevolezza (rendere conscio l’inconscio), piuttosto di sopportare l’ansia di rimanere in territori sconosciuti, di spiegare le trame relazionali che ci includono, rinunciando alla razionalità di una spiegazione unica, uscendo dalla stanza, sporcandoci le mani, accettando il dubbio e il pensiero ipotetico.
Non ho fatto altro che evidenziare i pregiudizi sistemici che guidano il mio agire. La necessità non di curare o risolvere problemi quanto di essere utili, innovativi, di decostruire le storie con le quali le persone si presentano. Di perturbare e trasformare, di costruirmi ipotesi che mi permettano di intervenire in base al dialogo che insieme agli altri ho costruito. Vorrei evidenziare per finire alcuni pregiudizi che hanno sempre guidato le mie azioni e che facilitano la messa in atto delle operazioni che ho suggerito.
- una persona ha valore in quanto esiste
- e’ impossibile controllare, influenzare e manipolare gli altri
- la tipologia è un mito
- le spiegazioni servono più a noi operatori che al processo
- dovremmo essere guidati da certezze temporanee anziché da verità permanenti
- prima di pensare di cambiare il mondo proviamo ad apprezzare come funziona.
Bibliografia
Anderson H., Goolishian H., 1988. Human Systems as linguistic systems. In Family Process, 27, pp.371-394.
Bianciardi M., 1999. “Autonomia del vivente e criteri diagnostici”. In Connessioni nuova serie, n. 5, pp. 41-55.
Bianciardi M., Galvez F. (a cura di), 2012. Terapia come etica. Responsabilità clinica e condizione postmoderna, Antigone, Torino.
Bianciardi M., Telfener U., 1995. Ammalarsi di psicoterapia, Franco Angeli Ed., Milano.
Cosmacini G., Satolli R., 2003. Lettera a un medico sulla cura degli uomini, Laterza, Bari.
Donghi P., Preta L., 1995. In principio era la cura, Laterza, Bari.
Fruggeri L.,2008. Diverse normalità: discontinuità familiari e modelli di analisi. In Chianura P. et al. (a cura di), Le relazioni e la cura, Franco Angeli, Milano.
Foerster H.(von), 1987. Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma.
Hoffman L.,2001. Family Therapy, an intimate history, Norton, New York.
McCarthy I. (2010). The Fifth Province: Imagining a Space of Dialogical Co-Creations, in Context, Dec, pp 6 – 11.
Telfener U., 2011. Apprendere i contesti, strategie per inserirsi in nuovi ambiti di lavoro, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Telfener U.,2011 (b). Gli operatori tra più fuochi, in Minori e giustizia, N°4, pp.156-171. Telfener U., Casadio L., 2003. Sistemica, voci e percorsi nella complessità, Bollati Boringhieri, Torino.